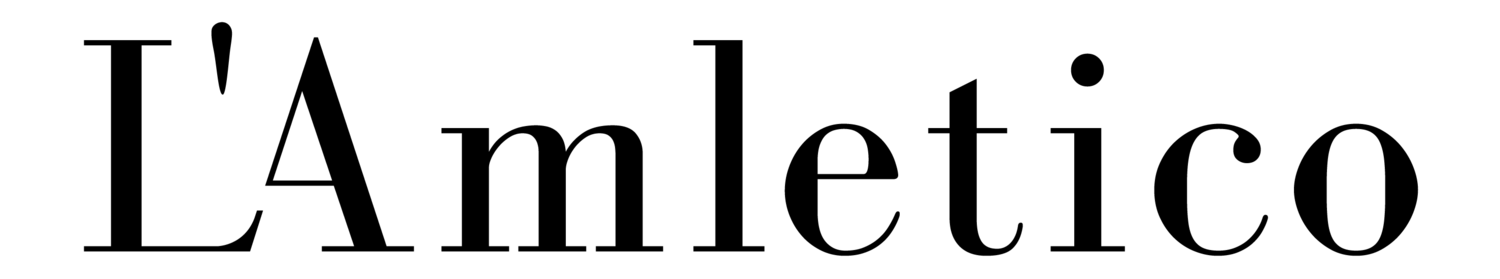Dirette deformanti: per un’iconografia surreale di Roccaraso “invasa”
Un sogno di neve puro, che si scioglie all’improvviso. Non è (solo) colpa del riscaldamento climatico, o del rumoroso engagement di Rita De Crescenzo. Roccaraso si è scontrata con la sproporzione di un fenomeno di rara voracità, che denuncia implicitamente la violenza delle nuove narrazioni che si fanno del nostro territorio attraverso Instagram e TikTok, delle consuetudini borghesi che avvolgono un luogo selvatico: la montagna.
Quello che è successo alla cittadina abruzzese ha dominato la scena social per giorni. Una notizia frivola, nel caos di un web scosso da questioni ben più urgenti e drammatiche, che tuttavia offre spunti di riflessioni sull’esperienza turistica oggi, su cosa c’è di “reale” nel visitare una meta ambita. Ambita, o resa desiderabile per motivi più o meno vari. Roccaraso non è certamente Cortina, eppure per chi viene dal sud rappresenta – anche banalmente per motivi di vicinanza geografica – un centro allettante per trascorre la settimana bianca. Per questo motivo, oltre agli appassionati del trash, si sono interessati alla notizia anche certi personaggi che ci hanno tenuto a porre la questione in termini etici: nell’indignazione condivisa aleggia lo spettro dell’antimeridiolismo? Oppure si tratta di semplice snobismo? Al là di facili prediche e moralismi, la storia è molto più semplice, e al contempo, complicata. Come il ghiaccio, resistente ma trasparente, che si sta facendo velocemente più sottile in questi mesi, e che sta scomparendo, come chi credeva che l’ideologia woke avrebbe costituito un vero progresso morale per la società. E invece ci troviamo personaggi caricaturali da meme al potere.
Etica 2.0 e degrado: un dittico tutto virtuale.
Claudia Fauzia, autrice insieme a Valentina Amenta di Femminismo terrone. Per un’alleanza dei margini (2024), edito da Edizioni Tlon, sulla sua pagina Instagram ha fatto delle storie tacciando la sparata contro l’“invasione” di Roccaraso come una polemica antimeridiolista. Non è stata l’unica a fare un simile parallelo, ma ad ogni modo è interessante notare il fatto che i concetti-slogan della cultura woke ora stiano prendendo piede in Italia creando a loro volta nuove versioni degli stessi, apparentemente legati alla specificità della nostra cultura. Se l’antimeridionalismo certamente esiste, fa un po’ ridere pensare che la trovata tutta social – e inscritta sotto il segno del trend del momento: il trash – racconterebbe dell’odio verso il popolo dei Napoletani. Cosa c’è di autentico in quel carrozzone pacchiano di macchiette e stereotipi esasperati all’inverosimile? È vero che questo circo produce effetti reali, come la schiera di pullman che si sono affollati a Roccaraso, ma è lecito domandarsi cosa ci sia di reale in tutto ciò. Non sembra, piuttosto, una grande allucinazione? D’altra parte anche le grandi illusioni nella storia hanno fatto “storia” a loro volta.
Sappiamo che il confine fra reale e irreale è assai sfumato, ma non bisogna cedere al relativismo postmoderno, perdendo la bussola in discorsi retorici intellettualoidi, o in facili sparate ideologiche, cercando di cavalcare la sensibilità del momento. Vincenzo Profeta, in Il Nemico rivista, ha criticato il saggio Femminismo terrone. Per un’alleanza dei margini affermando che le donne del sud non hanno bisogno del suo “femminismo terrone” inscritto sotto il segno di un compromesso compiacente e, dunque, modaiolo. Secondo me questo è un ottimo punto dove partire per analizzare il discorso-Roccaraso. La critica sociale, figlia sia delle rivolte degli anni Settanta che della ricerca accademica, diventando “pop” non è servita quasi mai, purtroppo, a sradicare una narrazione comune ancora razzista, misogina, omofoba, patriarcale ecc., venendo ben presto risucchiata nella maglia di interessi capitalisti, nel mercato della cultura dove le minoranze non sono altro che una nuova fetta di pubblico. Ora, mettere nello stesso calderone le persone ghettizzate per la loro origine e appartenenza culturale, e Rita De Crescenzo che non fa altro che lucrare su quegli stigmi mettendogli strass e lustrini, mi sembra parossistico, almeno come le sue mise che la rendono, giustamente, simpatica a tante persone. Se si guardasse però l’alienazione che spinge a certe derive, con lucidità, si potrebbe risalire con più efficacia alle fondamenta dei condizionamenti culturali che portano alla discriminazione, per criticarli e decostruirli, ma questo lavoro ovviamente è invisibile, e quindi non si vende né si vede bene. In questo sono affini questi trend – che siano “colti” o meno – che nascono sui social e muoiono sui social, facendo girare l’economia nel frattempo.
Vette di trash
Guardando le immagini dei bus e dei turisti che affollano Roccaraso ho pensato al celebre quadro di James Ensor L’entrata di Cristo a Bruxelles (1889). Il tema religioso non c’entra nulla, o forse sì, visto che si segue oramai l’influencer di turno come una divinità, con una cieca fede che rimanda anche a un folklore pagano o medievale. La figura di Cristo, nella sua infinita bontà, è un po’ folle, tanto da ispirare diffidenza e ammirazione sfrenata. La stessa gente che l’ha portato alla crocifissione, ora lo esalta, rapita in un’estasi collettiva grottesca. Pure la folla è un po’ folle, e lo sono anche i paladini del trash che i follower idolatrano dicendo che sono “mitici”. Questo climax porta all’esasperazione un’esigenza di realtà che – insoddisfatta del “realismo” grigio del primo decennio del 2000 – ora vuole spingere tutto all’estremo, fino a odorare, sbranare, vomitare il reale attraverso l’immagine. Quindi vediamo queste dirette che catturano momenti di simulata intimità, con prospettive che ci fanno vedere i pori dilatati o i peli del naso dei divi del momento. Oppure no, vediamo truccatissimi questi stessi segni del reale che appaiono ancora più irreali in questa dialettica di scabrosa oscenità e curatissima messa in scena.
TikTok, più che Instagram, ha inaugurato un nuovo tipo di estetica: quella del mostruoso-reale, che ci fa sembrare “normali” le esibizioni più impudiche di frammenti della vita quotidiana, simulata o semplicemente deformata dallo schermo. Non è realtà “senza filtri”: è la parodia di un bisogno di contatto e di dialogo, che si perverte in un voyeurismo macabro nel suo essere banale. Perciò lo sdoganamento del folk non consiste nell’accettazione della realtà “così com’è”, senza sfarzo né filtri (che ora sembra quasi non esistono più), ma consiste nella normalizzazione dell’alienazione sociale, che ha portato (fra le varie cose) anche al successo di “mostri” dei social che con le loro buffonate sono diventati leader mondiali, conquistando le vette del mondo. Il Novembergruppe, un’associazione di architetti, al termine della prima guerra mondiale, aveva ipotizzato delle città utopiche costruite sulle Alpi, ispirandosi alla forma pura e perfetta del cristallo. È strano pensare come la montagna, nell’utopia di tutti i turisti napoletani che hanno intrapreso questo viaggio allucinato, rappresentava veramente un’ideale perfetto: tanto lo era nella loro testa, quanto invece quest’immagine nella realtà appariva caotica e degradata come quella restituita dalle testate giornalistiche.
Il simulacro della neve
La neve è quel velo che ricopre indistintamente tutto, che attenua i contrasti, che ammorbidisce sotto un soffice manto bianco tutto ciò che il nostro sguardo non può sintetizzare in un unico colpo d’occhio. Ma il bianco a Roccaraso non è più tale, c’è un fenomeno di saturazione in corso. La montagna è satura, lo è il web e anche l’aria che sta sciogliendo i ghiacci nella nostra Europa sempre più calda, oltre le medie mondiali. C’è un che di puro, tuttavia, nel sognare, nonostante tutto, la neve, nello scalare una montagna per viverla nella sua altezza, nel tentare di raggiungerla, come un’ascesa celeste, verso le nuvole, un universo etereo di infantile e spirituale piacere. Come rispettare questa aspirazione? Come nobilitare quello che c’è di bello in noi senza idealizzare – e produrre i mostri nel reale –, senza distruggere il reale per sguazzare nelle fantasie venduteci (a caro prezzo) da qualcun altro? Forse solo sognare, e ancora sognare ci aiuterà a svegliarci da questa follia condivisa che ridicolizza tutto, e insensibilmente raggela l’ironia in un mondo che improvvisamente sa diventare paurosamente serio. Come recita un vecchio proverbio turco: “Se un clown si trasferisce in un palazzo non diventa il re, è il palazzo che diventa un circo”. Allora, per ri-connetterci con noi stessi, iniziamo a far sloggiare certi personaggi dal nostro immaginario, popolandolo, piuttosto, di figure alternative agli idoli del trash che malamente imitano i grandi capisaldi del genere, e che sono sepolti oramai neanche sotto la neve, ma sotto un deserto di sabbie mobili.