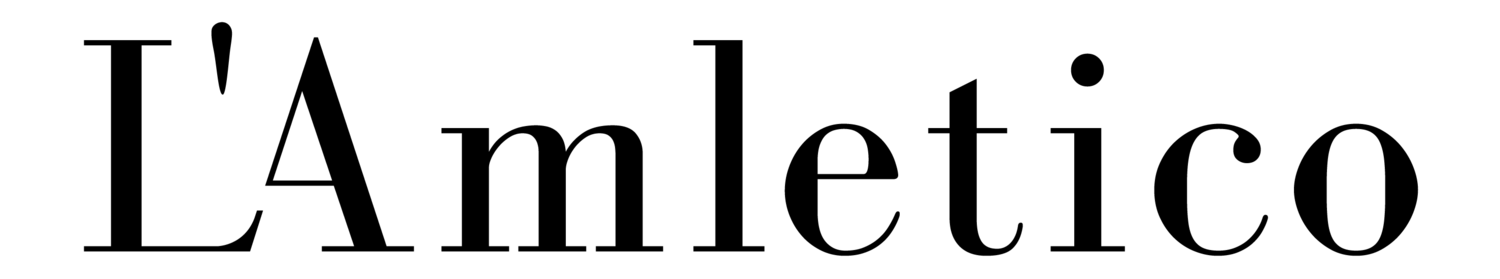Elegia del verde nelle città roventi
L’estate si fa sentire: la sua morsa è come una tenaglia da cui non si può sfuggire che zuppi di sudore. Il cielo si sbianca nell’accecante intensità di un sole che opprime senza ristoro. Il tenue ceruleo del cielo primaverile lascia il posto a un fulgore giallino, anche se questa percezione è visibilmente alterata dalla sensazione di pesantezza che fa cadere nel torpore. Sono lontani i tempi delle leggere brezze, delle folate che accarezzano i volti come spighe di grano fiorite. Anche il sonno si fa pesante senza l’aiuto di un condizionatore. Il grande caldo è una grande condanna, e le città italiane sono sempre meno attrezzate a gestirlo, specie se vogliono restare vive e non prigioniere di bunker di frescura artificiale. Ma come fare quando, sulla soglia di casa, si apre la porta sull’esterno, o meglio sull’inferno?
L’alleato su cui contare per sopravvivere nelle giornate, e nelle ore, peggiori è diventato per molti il primo responsabile di morti atroci ed evitabili: l’albero, il killer urbano per eccellenza secondo molte testate giornalistiche, che cavalcano l’onda di qualche raro crollo – come quello avvenuto recentemente a Venezia – che diventa subito virale. Si crea così un clima di isteria collettiva, dove la motosega sembra paradossalmente uno strumento salva-vita. Mentre in televisione Francesca Fagnani con Belve crime sdogana le storie di cronaca nera, i suoi protagonisti discutibili trasformati in personaggi pop, ci si accanisce contre delle piante che non fanno altro che subire l’effetto di anni di trascuratezza, o di politiche selvagge dall’apparenza progressista. Infatti, dietro la strategia del greenwashing, spesso si dimentica la natura culturale di queste forme di vita, che non posso essere separate dal patrimonio artistico delle città, che vengono sradicate per essere sostituite con “stuzzicadenti” comprati con i fondi europei. Eppure qualcosa sta cambiando, nella consapevolezza collettiva, nello scontento di chi vede i propri quartieri vandalizzati, e bisogna continuare a dare forma a questo sentimento, a parlarne, affinché diventi qualcosa di sempre più presente nel discorso pubblico.
Benvenuti all’EUR: nella nuova piazza Augusto Imperatore
Roma è una città che si è (ri)costruita sulle sue rovine. Non solo la chiesa di San Clemente, non solo i suoi spazi sacri e storici: tutta l’Urbe è un grande movimento centripeto, un continuo ritornare su sé stessa sempre reinventata, degradata nel tentativo di sopravvivere e rifarsi nonostante l’impossibilità di liberarsi dal pantano della storia. In questo panorama, ci sono alcune opere di rivalutazione che fanno discutere. La recente inaugurazione della piazza di Augusto Imperatore ha creato scontento fra molti. Si lamenta, infatti, la pressoché totale assenza di alberi, se non qualche sparuta presenza messa in un angolo, messi dunque come nel ghetto. A dominare la visione generale non è una “grande” piazza tuttavia, ma una strada larga completamente concepita non per i pedoni, ma per il sole rovente. Si parla di design moderno e minimalista, di scelta consapevole per non ottundere la vista del Mausoleo di Augusto, ma la verità balza all’occhio: è semplicemente cocente. Nessuno in estate attraverserà quella strada godendosi la poesia della storia o la magia dell’arte (anche perché i brutti edifici fascisti non aiutano), ma penserà solo a correre il più velocemente possibile dall’altra parte. Una piazza che diventa una versione meno funzionale di un’autostrada non può che essere un fallimento urbanistico. Eppure bastano dei tocchi “stilosi” e l’austerità subito sembra alla moda, al passo coi tempi, mentre le lamentele vengono viste come opera esclusiva di burberi passatisti o di folli amanti del verde, che già si bolla di irrazionalismo e fanatismo. In fondo, non è coerente questo passaggio che collega una colata di travertino con quello scatolone losangelino, stile villa con piscina a Malibù, del Museo dell’Ara Pacis? Passando sotto un simil-viadotto, scorrendo lungo una specie di loggiato che fa pensare – nella su fisionomia orizzontale – a un autogrill.
Il Mausoleo di Augusto, c’è da dire, nella sua storia non ha avuto pace. Già nell’epoca fascista era stato scoperchiato, o meglio era stata distrutta la struttura che proteggeva il “dente cariato”. Chiaramente non si trattava di “curare” una rovina in stato di degrado, ma di vivificare un concetto, quello dell’autorità imperiale e dei suoi volti simbolo. In questo caso, poco importava quello che veniva alla luce, poco importava quello che si demoliva, perché l’intento era ideologico. Il quartiere dell’EUR nasceva con un medesimo intento retorico, fornendo tuttavia una più coerente e didascalica visione dell’antichità in auge all’epoca. L’estetica che domina ancora oggi quelle vie e quelle piazze, infatti, non è soltanto composta da geometrie elementari e semplificazioni di elementi tipici dell’architettura romana, ma anche da un impianto scenografico che ben poco si adatta alla scala umana. Ancora una volta le ruote di un’automobile sono preferite alle gambe, in assenza di ombra e verde (anche alla luce dei recenti abbattimenti), in presenza di un qualcosa che vorrebbe essere metafisico e invece è solo vuota propaganda. L’eredità storica di Roma era vista come un monumento a-temporale, e anche a-critico, che pesava come un macigno, che si imponeva come un modello autoritario in cui le persone non potevano che essere passivi spettatori. Il progetto fantasmagorico che voleva che le sue prospettive maestose, e un po’ funebri, si estendessero fino al mare, come il Pireo ateniese, sono venute meno, ma i sogni di gloria, si sa, sono duri a morire.
La nuova piazza Augusto Imperatore rientra precisamente in questo immaginario. Blocchi di travertino, linee nette, volumi pesanti. La mancanza di una scala umana ha come conseguenza l’eliminazione dell’elemento organico, e quindi anche il verde, della sua moltiforme capacità di interagire coi contesti. Una pianta, oltre a fare ombra, raffreddare l’aria e migliorarne la qualità, costruisce una sua temporalità viva radicandosi con la storia dei luoghi, creando sinergie con il contesto. Un albero abbraccia un monumento, non lo copre, perché i suoi cicli vitali sono vari, non c’è mai un'unica immagine dell’albero, c’è la sua crescita, la sua espansione e il suo ripiegarsi in sé stessa. Come non pensare all’uomo e il suo rapporto con la storia artistica/architettonica/urbanistica in tutto questo? se le radici di un platano o di un pino marittimo distruggono il palco e la platea, il “teatro” della città diventa un luogo infinitamente più accogliente. Si può contemplare, si può passeggiare, si può correre: gli atteggiamenti sono i più vari, ogni scorcio può catturare l’attenzione perché è pensato per dialogare con noi. Ma la minaccia arborea spaventa chi ha il terrore di un approccio democratico alla cultura, alla bellezza, al benessere: meglio creare delle isole separate in cui fruire di piante esotiche e rare, messe ai margini dal centro abitato. Nemmeno il parco, no, perché lì ci devono essere altre radure assolate, come nel caso dei terribili giardini di via Sannio, dove stanno abbattendo gli ultimi alberi che erano stati salvaguardati dal cantiere della metro C.
Ma quando il sipario cala, e la luce torna a illuminare il teatro apparentemente eco-friendly, cosa si vede?
Un colonnato caduto
“Gli alberi muoiono, le piante hanno un loro ciclo di vita come le persone”, si dice troppo spesso oramai, e con l’incedere di questo intercalare gli alberi monumentali spariscono, gli scorci perdono la loro bellezza, mentre con il bonus facciate gli edifici storici restaurati si tramutano nella loro controparte presente negli outlet che costellano la penisola. Così, insensibilmente, con i palazzi sempre più moderni – loro malgrado – le strade si spogliano, lasciano spazio alla modernità tardo capitalista di un mondo sempre più sintetico, a mo’ di rendering. Gli alberelli di piccolo formato, infatti, che qualche volta vengono ripiantati, sono come le parodie di quelli precedenti. Sembra come se gli si dicesse “fate i bravi eh! Non crescete troppo” e si lascia loro pure poco spazio, così che timidamente, se devono morire a causa della siccità, lo possono fare con discrezione. In fondo, piccoli e sottili come un fuscello, non si faceva nemmeno caso a loro. Un trapasso indolore si direbbe. Ma non sempre quest’opera di sostituzione accade, a volte le ferite restano ben visibili come cicatrici aperte… che aspettano in vano di essere ricucite.
Il trauma di interi filari di alberi “castrati” è diventato onnipresente a Roma. A volte si procede poco alla volta, come a non voler dare troppo nell’occhio, a volte invece si compie una distruzione di massa: dall’oggi al domani si abbatte tutto. A volte certi casi diventano mediatici, a volte passano in sordina, come nel caso dell’Emiciclo di Nettuno di Piazza del Popolo. Al posto di maestosi alberi sono stati piantati dei piccoli cipressi, soluzione che si sta adottando spesso, come a dire: ecco il cimitero del verde. In ogni caso, lo spettacolo della devastazione di tronchi recisi richiama quello degli antichi colonnati devastati dagli assalti dei popoli germanici, dalle guerre, dagli incendi, dall’incuria. La forma della colonna ha un enorme valore simbolico nella cultura mediterranea e non solo. È un elemento architettonico fondamentale, che dialoga con altre elementi orizzontali, che si collega a loro volta ad altre colonne, o a muri, pilastri. In ogni caso il suo sostenere è sia letterale che metaforico: il suo slancio verticale che fiorisce in un capitello trionfante richiama la vita organica e la sua capacità di espandersi in armonia nel mondo. Ma agli alberi dalla chioma aperta – come dicevo prima – vengono preferiti cipressi cimiteriali, per far si che questo slancio venga castrato, o vengono scelti alberelli minuti, come i ligustri che dopo anni di piantumazione sembrano sempre il tipico alberello che disegna un bambino, per far capire che non si potrà mai creare una reale sinergia fra più alberi, lasciandoli infantili e isolati. Un modesto tributo green.
Ma perché l’albero è diventato “la pietra dello scandalo” del discorso sul verde urbano? E perché il suo “crollo” ci dice tanto di una nuova fase di decadenza che coinvolge più noi che lui?
Crocevia e motoseghe
Il bonus facciate ha fatto fuori i rampicanti di molti palazzi storici, che sono stati restaurati e dipinti di colori sgargianti e sintetici, come la pasticceria dei dolci americani. I bordi e le cornici rigorosamente bianchi come la panna, e l’interno dei “riquadri” rosa come fragola, giallo come limone, arancione come il mango, e così via. La glassa è, in quest’ottica, quel trattamento che impedisce al “sublime sudiciume” che amava John Ruskin – la patina del tempo – di attecchire sui muri. Queste sono le case che si vendono meglio su Airbnb, perché sembrano uscite da una cartolina stereotipata dell’Italia. E la soprintendenza? E i vincoli? Voi direte, ma non sempre i “nemici” della storia nelle sue forme culturali e naturali è un imprenditore spietato e affarista, e può prendere le forme anche di un personaggio colto.
Quando studiavo architettura, e durate un esame di progettazione bisognava creare un ipotetico intervento nel quartiere di Trastevere, per riempire un vuoto che veramente esiste a Via dei Salumi, ebbi un’istruttiva conversazione col mio docente. Mentre i miei colleghi ideavano scatoloni decostruiti – con finestre a nastro e balconi vertiginosi – oppure disegnavano a malincuore surrogati minimalisti di palazzi antichi con la “concessione” di un tetto tradizionale con tegole di cotto, io pensai di proporre un qualcosa che prevedeva un grosso rampicante di edera sulla facciata. Il professore, pur non rigettando l’idea, disse però che un progetto architettonico ben riuscito deve bastare a sé stesso: coprire l’abitazione che si è progettato col verde segnala una forma di insicurezza. Aggrapparsi a una copertura naturale, inoltre, tradisce anche una forma di timidezza… insomma, rimasi molto perplesso da questa affermazione. Il semestre successivo il professore di storia dell’architettura ci mostrava a lezione delle slide con fotografie di una Milano razionalista, in cui ammirava la bellezza di queste forme “pure”, esaltate dall’assenza di alberi… oggi invece, dovreste vedere – diceva con rammarico – come il viale alberato ci ha privati di questa visione senza filtri. Insomma, l’ego di categoria non poteva che esprimersi contro l’interesse di tutti, anche dell’architettura stessa, che invece nel dialogo col verde ha mostrato nella storia numerosi e illustri esempi, sia nella storia antica che contemporanea, che contraddicono questa subordinazione di opera dell’uomo vs opera naturale.
Ma i nemici si situano su tanti fronti, e un altro formidabile avversario del verde è oggi la stampa. Il giornalismo, infatti, ha avuto un brutto impatto sul tema degli alberi e le città. Certo, il clickbait fa parte di un discorso molto ampio, e non si drammatizza solo sul crollo di un ramo. Ma bisogna smetterla di criminalizzare gli alberi, di raccontarli come dei killer “morti in piedi” – si dice, quando sarebbero secchi – come se fossero degli zombie pronti a uccidere. È troppo facile metterla in questi termini, farli passare per degli “estranei” nella città, degli elementi scomodi ed eliminabili. Roma – ogni anno – raccoglie tantissimi incidenti, e tantissime persone muoiono di caldo, ma nessuno si accanisce veramente contro questa due problematiche. Fa caldo? Allora tocca difendersi, non uscendo nelle ore clou. C’è stato un incidente? Che cosa terribile, bisogna stare attenti. Non si può ridurre il numero di incidenti e di morti con delle soluzioni pratiche e dirette, ma si possono creare una serie di misure per impedire che ciò accada. Solo che nessuno – né il giornalista medio né il cittadino medio – si accorgerebbero di questi cambiamenti, perché si cercherà sempre l’immagine “immediata”, che si traduce o in una misura drastica o in un risultato perfettamente visibile (dunque fittizio), in grado di far provare nel lettore dell’articolo un senso di compiacimento catartico. Ma non può essere così semplice, perché la vita in città, il suo rapporto con la storia e il verde, è un tema complesso, articolato da motivi che intercettano anche questioni riguardanti la salute, il progresso e così via.
Il punto è che per contrastare tutti i veri problemi essere bisogna sempre essere lungimiranti, andare oltre l’immediatezza, pensare e prevenire il disastro, laddove contro gli alberi si prende sempre la soluzione più brutale: l’abbattimento. Ma se finisce al telegiornale la persona che muore colpita da un albero, dove vengono raccontate, invece, le persone che schiattano sotto la calura di luglio? Come raccontare il disagio di chi deve camminare – come nel deserto – in strade che un tempo erano protette anche dalla bruttezza di una certa speculazione edilizia che ha rovinato il paesaggio urbano? Non esistono per i mass-media tutte queste “altre” persone, diventano troppo velocemente insensibilmente anonime. Lo vediamo bene che esistono morti di serie A e serie B a livello mediatico, come è accaduto anche con i casi di cronaca dei femminicidi, dove in base all’immagine della donna o della ragazza ammazzata si costruisce una narrazione più o meno efficace, capace di creare sdegno e mobilitare proteste. A volte semplicemente chi viene uccisa ha poco carisma, e così la sua vicenda cade nell’oblio. Pure gli alberi a volte hanno delle storie epiche, e quindi la loro uccisione causa un’ondata di sdegno collettivo, come nel caso dell’insensato abbattimento del Sycamore Gap Tree in Inghilterra, conosciuto anche come l’albero di Robin Hood.
La minaccia di città sempre più spoglie però, non tanto dei suoi alberi “simbolo”, è sempre più reale: cosa succederà quando saranno quasi spariti gli alberi monumentali? Quando l’albero più alto arriverà massimo a tre metri altezza? Le città sempre più calde rischiano di somigliare pericolosamente alle citta del medio-oriente, che vengono vissute solo all’interno di centri commerciali e altri edifici commerciali e pubblici, tutto raffreddato artificialmente. Ma l’aria condizionata non è una soluzione “sociale”: è individualistica. La rabbia dei residenti dei quartieri assaltati da motoseghe, invece, non lo è: chi protesta contro una distruzione che sta a cavallo fra monumento storco e naturale si mette al crocevia di diversi discorsi, e lotta per garantire una comunicazione fra tutte queste forme di bellezza e benessere, permettendo di far si che una temporalità passata si rinnovi nel futuro. Nessun fanatismo dunque, nessuna risposta emotiva esagerata. La sola risposta emotiva è quella che esplode dopo che un albero crolla, e per “sicurezza” (o rappresaglia?) ne vengono abbattuti altri dieci, per porre uno sbrigativo argine all’isteria collettiva che intanto è già dilagata.
Allora, diamo non benzina, ma linfa, alla rabbia che esplode davanti allo scandalo di una distruzione evitabile, perché le persone sensibili al tema sono sempre di più, e stanno facendo già tanto per proteggere il nostro patrimonio arboreo, attraverso l’opera di associazioni che vanno in prima persona a vigilare sul territorio, e anche a protestare correndo grandi rischi. Ma molte di queste battaglie, come gran parte dei veri gesti eroici, resta invisibile agli occhi dei più, sebbene chiunque possa beneficiare dei loro trionfi, stendendosi sotto un ramo rigoglioso, respirando la sua silvestre brezza. Il verde, d’altronde, è il colore della speranza.